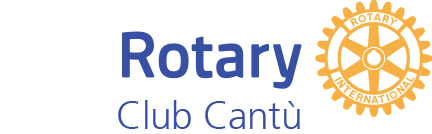30 Novembre 2021
La globalizzazione, intesa come l’insieme delle relazioni tra le diverse regioni del mondo, è un fenomeno antico che ha avuto alterne vicende nel corso della storia, vedendo prevalere ora l'una ora l'altra delle aree di sviluppo della civiltà.
Troppo spesso l'occidente credendosi al centro della storia ha dimenticato che l'oriente ha avuto un peso prevalente, sia nello sviluppo tecnico-scientifico che in termini di PIL complessivo, superiore a quello europeo fino a tutto il 1500, a testimonianza di una consistenza economica non certo trascurabile. La sfida tra oriente e occidente sta riproponendosi in questi anni, anche sulla scia del trauma delle delocalizzazioni, da qualche anno un incubo per l’occidente. Se ne è discusso al ROTARY CANTU’ nella serata di martedì 30, con la partecipazione di numerosi soci interessati allo sviluppo dei processi industriali contemporanei, commentando un libro dell’economista Richard Baldwin, introdotto da uno dei soci.
LA GRANDE DIVERGENZA TRA OCCIDENTE E ORIENTE (1800-1900)
Per ripercorrere la vicenda negli ultimi secoli, giova ricordare la svolta decisiva avutasi alla fine del 1700 che ha visto nascere la rivoluzione industriale in Gran Bretagna. Contemporaneamente Cina e India si deindustrializzavano e si chiudevano ai rapporti commerciali con l'Occidente, che aveva già avuto la grande stagione delle scoperte geografiche ed allargato enormemente i suoi orizzonti commerciali. Con la fine delle guerre napoleoniche anche l’Europa continentale dà l’avvio all’industrializzazione. L'uso della macchina vapore nell'industria e successivamente in campo nautico e ferroviario nel corso dell'Ottocento hanno dato un impulso decisivo alla modernizzazione del Nord del mondo con la riduzione fortissima dei tempi e dei costi di trasporto. È del 1819 la prima traversata dell’Atlantico con una nave a vapore il cui utilizzo presto ridurrà di due terzi il tempo necessario impiegato con la navigazione a vela. Risale al 1866 la stesura del primo cavo transoceanico tra Stati Uniti ed Inghilterra che realizza con il telegrafo una prima rivoluzione nella comunicazione tra i continenti. Dalla macchina a vapore al motore diesel, molto più efficiente, applicato sulle navi in acciaio. L’innovazione ha richiesto alcuni decenni, rendendo i rapporti commerciali ancora più semplici e meno costosi. La globalizzazione è molto più avanzata che in passato nonostante che Cina e India non abbiano tenuto il passo della modernità. Tutto L'Ottocento e buona parte del Novecento sono stati contrassegnati dalla cosiddetta “grande divergenza” fra mondo orientale sottosviluppato e mondo occidentale sviluppato e fortemente industrializzato, che ha continuato ad alimentare l'innovazione tecnico-scientifica al suo interno.
LA GRANDE CONVERGENZA DAL 1990 AD OGGI
La svolta in senso contrario si è avuta alla fine del secolo scorso, anni ’90, con la formidabile innovazione dell'ICT (Information and Communication Technology) che ha rivoluzionato il nostro modo di comunicare e le nostre capacità di calcolo, oltre ad aver innestato una rete WEB di interconnessioni impressionante. La globalizzazione ha cambiato completamente aspetto risolvendosi in una “grande convergenza” tecnico-economica tra oriente e occidente senza precedenti. Questa rivoluzione della comunicazione e dell’informatica che ha seguito dopo più di un secolo il crollo dei costi di trasporto e la forte riduzione della loro durata, ha dato l’avvio ad un processo di delocalizzazione produttiva verso i paesi in via di sviluppo che ha coinvolto tutte le maggiori industrie dell'occidente, alla ricerca di bassi salari per diminuire i costi di produzione. Si è innestato così un fantastico processo di industrializzazione di tanti paesi del terzo mondo che hanno potuto combattere la povertà e hanno visto il loro PIL salire vertiginosamente, fino all’attuale esplosione della Cina, divenuta in pochi decenni “la fabbrica del mondo”, mentre i paesi del G7 in questi ultimi 30 anni hanno visto stabilizzarsi o scendere progressivamente il PIL e nel contempo si sono deindustrializzati. Il fenomeno si è concretizzato nelle “catene internazionali del valore”, create dalle multinazionali con il decentramento nei paesi in via di sviluppo, non dell'intera catena produttiva ma soltanto di alcune fasi di produzione, di alcuni moduli semplificati dell’intero processo, per evitare la necessità di maestranze particolarmente qualificate. La rivoluzione dell’ICT ha facilitato e abbattuto i costi delle comunicazioni internazionali con i paesi di recente industrializzazione, rendendo possibile un controllo a distanza dei processi produttivi. Tutte le fasi del decentramento hanno potuto essere agevolmente guidate lungo la catena produttiva e logistica, dispiegata spesso in paesi diversi. Altre innovazioni come l’introduzione dei container hanno contribuito a diminuire ancora costi e sprechi nei trasporti. Il fenomeno, di portata mondiale, ha avuto la conseguenza spostare i processi della concorrenza, che fino a poco tempo fa vedevano confrontarsi le diverse nazioni. Adesso sono le catene transnazionali di produzione cioè le multinazionali a contendersi i mercati con una continua ricerca di efficienza e di risparmio sui costi, oltreché di innovazione sui prodotti. Le delocalizzazioni hanno sicuramente favorito la lotta alla povertà nel terzo mondo ma hanno messo in crisi l'occupazione nei paesi occidentali.
Prima conclusione: alla luce del processo di internazionalizzazione in atto e della perdurante ineludibile concorrenza tra le multinazionali, c’è da dubitare che le legislazioni nazionali siano in grado di porre un freno a questi processi di delocalizzazione.
Seconda osservazione relativa ad un’ulteriore innovazione che sta mettendo in crisi l'occupazione: lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e della robotica ha consentito, ad esempio alla taiwanese Fixconn, la maggiore produttrice mondiale di componenti elettronici, di sostituire, già qualche anno fa, 50.000 operai, di una fabbrica che ne contava 110.000, con sistemi di produzione robotizzati. Un futuro analogo si prepara per diverse altre multinazionali come Apple e c'è ragione di temere che il fenomeno sia inarrestabile, non solo per l'Occidente ma anche per gli stessi paesi in via di sviluppo. È una cambiale in scadenza per i lavoratori poco qualificati di tutti i processi industriali e un campanello d'allarme per il nostro sistema formativo che deve preparare i giovani all’ingresso in un mondo del lavoro che, salvo poche eccezioni, sarà aperto solo alle professionalità un tempo elevate.